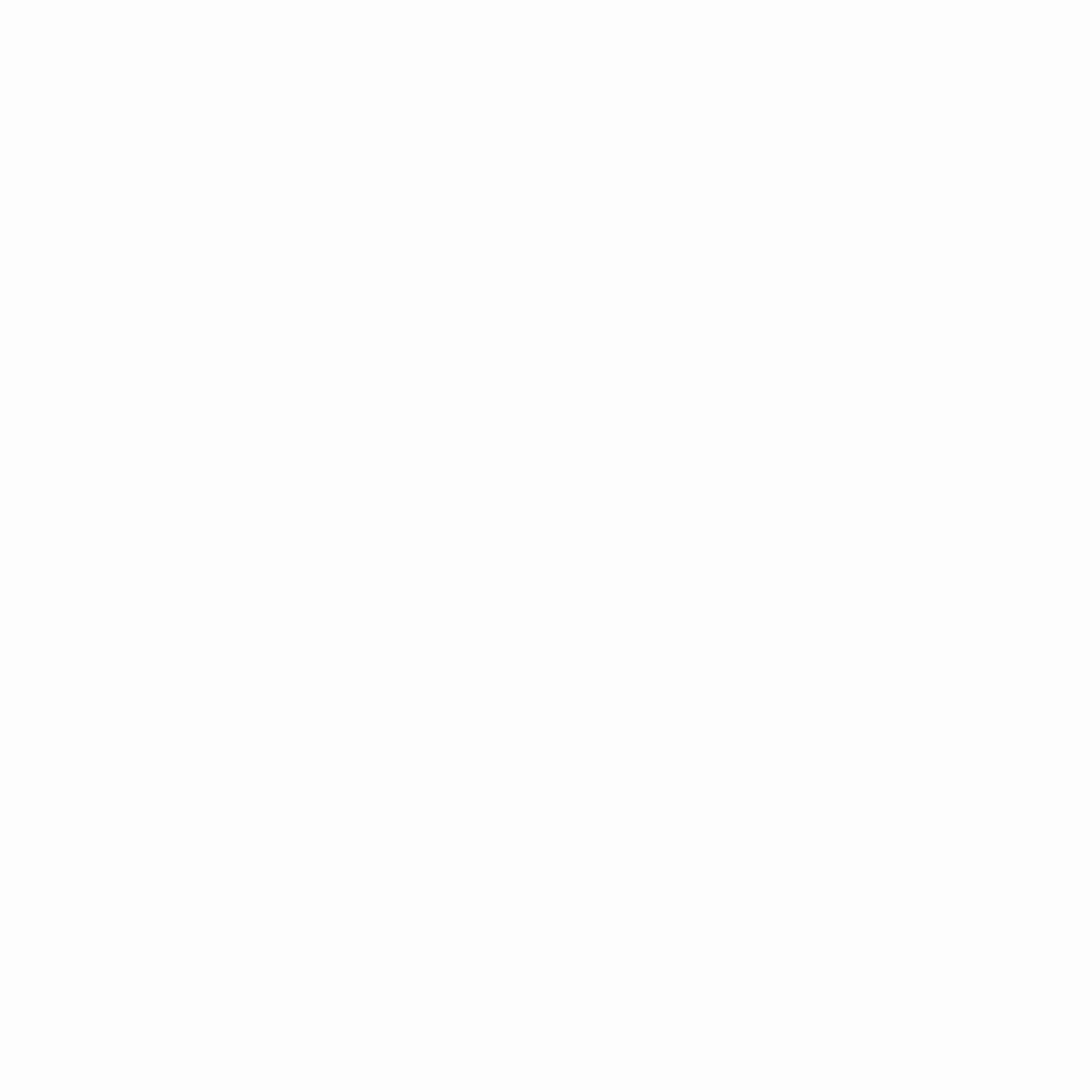
2024-2-5 17:1:24 Author: www.guerredirete.it(查看原文) 阅读量:15 收藏
Quella tra tecnologia, lavoro e profitto è un triangolo burrascoso che risale alla rivoluzione industriale, quando le macchine hanno iniziato a riconfigurare sistematicamente la relazione fra questi tre fattori.
Da allora, la tecnologia si è evoluta a enorme velocità facendoci passare dalla macchina a vapore a complicatissimi algoritmi in grado di migliorare automaticamente le loro capacità. Il comune denominatore di queste trasformazioni è sempre stato uno: la lotta senza quartiere per il valore generato da queste macchine.
La crescita dell’AI ha riproposto il dibattito sul Reddito di Base Universale
Da sempre, gli interessi economici hanno trainato lo sviluppo e l’implementazione delle tecnologie di automazione, e da sempre la società civile ha cercato di partecipare alla conversazione sulle politiche relative al loro uso.
Chi beneficia dell’introduzione di una tecnologia nel processo lavorativo? Come riconfigura i rapporti con la forza lavoro? Cosa faranno i lavoratori che verranno rimpiazzati? Sarà possibile formarli nuovamente? O questi sviluppi tecnologici sono il preludio di una spirale di precarizzazione sistemica?
Tutte queste domande (e molte, molte altre) giocano un ruolo politico decisivo nelle economie di tutto il mondo. L’opinione pubblica che si genera attorno a esse rappresenta un equilibrio fondamentale, e la stessa idea sulle capacità effettive di una tecnologia, su come si possa sviluppare e come sia in grado di riconfigurare i rapporti di forza condiziona le scelte politiche, per cui diventa un tema delicato anche dal punto di vista propagandistico (come nel caso del cosiddetto AI doomerism).
Perfino i luddisti sono tornati al centro del dibattito politico
Una discussione che ha anche strascichi nella storia. Oggi chi critica l’implementazione di alcune tecnologie come l’AI viene a volte bollato come luddista. Termine divenuto nell’uso comune quasi dispregiativo per indicare qualcuno che non solo non vuole una tecnologia, ma soprattutto non la capisce. Eppure questa è una semplificazione storica che negli ultimi mesi è stata ribaltata da vari articoli e libri, che l’hanno portata fuori dal dibattito storiografico per inserirla in quello politico. Tra gli autori di quest’operazione c’è il giornalista tech (quindi tutto meno che un luddista) Brian Merchant.
“A differenza di quanto si dice solitamente, i luddisti non erano idioti che distruggevano le macchine perché non le capivano. Erano operai tessili che una volta conducevano vite agiate, lavorando a casa o in piccole botteghe, secondo i propri termini e orari, con libertà e dignità,” spiega Merchant in un articolo per il Washington Post che racconta il suo ultimo libro dedicato proprio al luddismo (Blood in the Machine: The Origin of the Rebellion against Big Tech).
“Quando gli imprenditori tentarono di trasferire i loro lavori nelle fabbriche utilizzando telai meccanici e grandi telai che facevano un lavoro simile più velocemente, più economicamente ma restituendo una qualità minore, i Luddisti protestarono. Questi lavoratori cercarono prima un compromesso, un dialogo e un modo democratico per integrare la nuova tecnologia nelle loro comunità – per condividere i guadagni. Vennero ignorati. Così si ribellarono,” continua Merchant.
Non è quindi un caso che nel corso degli ultimi anni, dall’inizio del nuovo picco di popolarità per le implementazioni degli algoritmi di intelligenza artificiale, si sia amplificato il dibattito attorno al rapporto tra lavoro, reddito e tecnologia. Per alcuni, la crescita dell’AI è uno dei fattori più favorevoli per l’implementazione di un reddito universale di base (in inglese Universal Basic Income, o UBI), ovvero una misura di welfare per cui tutti i cittadini di uno Stato sono destinatari di un reddito regolare che viene distribuito a tutti, senza condizioni né requisiti da rispettare.
Il laboratorio sull’UBI e la prima conferenza mondiale
L’università di Bath (Regno Unito) ha creato un laboratorio che riunisce le competenze sul reddito universale di base e le sue intersezioni con le sfide sociali per trasformare le politiche pubbliche.
“L’interesse per il reddito universale di base è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni”, scrivono i ricercatori, che ad agosto hanno dato vita all’UBI Piloters Network, una rete che riunisce ricercatori, politici, attivisti e attori della società civile interessati o impegnati nella sperimentazione dell’UBI. Ne fa parte anche l’università di Friburgo (Germania) e in particolare il FRIBIS – Freiburg Institute for Basic Income Studies – un network interdisciplinare della citata università tedesca dedicato alla ricerca sul reddito di base universale. Riunendo ricercatori e soggetti della società civile di tutto il mondo, si propone di fornire una base solida per il discorso pubblico e politico sul reddito di base. Nel 2024 ci sarà la prima conferenza mondiale dei progetti pilota per il reddito universale di base.
Insomma, se questi algoritmi stanno diventando sempre più sofisticati e la loro diffusione sempre più capillare, quanto tempo ci vorrà prima che incidano sul mercato del lavoro? E, si chiedono alcuni, queste tecnologie aprono la strada all’idea di un reddito universale di base?
Cosa si intende con reddito universale di base
Prima di tutto: per poter parlare del rapporto tra reddito universale di base e intelligenza artificiale nello spazio di un articolo è necessario chiarire alcune premesse. Non si vuole approfondire qui la legittimità politica o meno di un reddito universale di base; né si vuole dare per scontato che le tecnologie di AI ridurranno sensibilmente i posti di lavoro. Qui ci limitiamo a raccontare come la conversazione sull’intelligenza artificiale stia influenzando il dibattito sul reddito.
Creare un reddito universale di base significa implementare un’erogazione monetaria regolare versata “da una comunità politica a tutti i suoi membri su base individuale senza controllo delle risorse né esigenza di contropartite” (P. Van Parijs, Y. Vanderborght, Il reddito minimo universale, Egea, Milano 2006, 5). Uno Stato, quindi, si ritroverebbe a fornire regolarmente del denaro a tutti i suoi abitanti (che siano cittadini, residenti o altro è tema di discussione) a prescindere dalle loro condizioni economiche o dal loro impiego nella società. Secondo i suoi sostenitori, il supporto fornito dal reddito universale di base alleggerisce le pressioni generate dalla precarietà e permette ai cittadini di negoziare condizioni di lavoro migliori e più stabili. Il ragionamento sarebbe il seguente: se queste erogazioni vengono finanziate dalle tasse, allora in prospettiva sarà possibile generare un circolo virtuoso in cui le tasse sui guadagni permettono di finanziare forme di welfare pensate per favorire l’incremento del lavoro, quindi dei guadagni, quindi delle tasse. Già oggi in Europa non mancano studi sull’impatto di diverse forme di welfare e sussidi rispetto non solo alla possibilità di trovare di nuovo un lavoro, ma anche su altri aspetti legati al benessere sociale.
Algoritmi che sostituiscono gli umani?
Ora i progressi nello sviluppo degli algoritmi di intelligenza artificiale hanno amplificato il dibattito sulla possibilità che le nuove tecnologie possano avere un’influenza importante sul mercato del lavoro – premesso che non è facile misurare questo impatto, anche se ci sono studi che ci provano.
Le capacità dei modelli di intelligenza artificiale sono infatti sempre più avanzate sia per i processi di analisi che per quelli creativi, ampliando di gran lunga la lista di lavori che, potenzialmente, potrebbero essere eseguiti da un algoritmo anziché da un umano (per esempio la scrittura di questo articolo?). Le sfumature, chiaramente, sono tante.
Non solo non tutti i lavori sono uguali, perché compiti simili svolti in contesti diversi potrebbero richiedere lavoratori con caratteristiche differenti – come la differenza tra un operatore di un call center commerciale e quello di un servizio di emergenza. Soprattutto nel caso dei cosiddetti lavori cognitivi, la consapevolezza umana risulta ancora una caratteristica fondamentale, imprescindibile e che non può ancora essere riprodotta dalle macchine, soprattutto in ambiti particolarmente sensibili come quello sanitario.
Resta però un fatto che l’attenzione nei confronti delle possibili implementazioni di questi algoritmi in ambito lavorativo sia aumentata a dismisura in tutti i campi, al punto da portare alla creazione di piattaforme come Will Robots Take My Job in cui diverse categorie professionali vengono analizzate sulla base della loro vulnerabilità ai progressi nell’automazione (che non coincide però con l’AI) e nella computerizzazione.
Mentre scriviamo su quel sito campeggia questo survey che chiede se servirà proprio un Reddito Universale di Base.
Differenza tra automazione e AI
Malgrado i due termini siano spesso appaiati, va ricordato che hanno significati diversi. L’automazione indica applicazioni tecnologiche in cui l’intervento umano è ridotto al minimo, e in genere automatizza compiti ripetitivi. Ad esempio, “l’automazione robotica dei processi è una tecnologia che automatizza i flussi di lavoro di back-office ripetitivi e laboriosi”. D’altro canto, quando si parla di automazione intelligente si intende la combinazione di tecnologie di intelligenza artificiale come l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l’AI generativa e altre tecnologie per semplificare le operazioni aziendali.
Dai dem alla Silicon Valley, l’idea di un futuro senza lavoro (e con quale reddito?)
Lo scorso settembre, Robert Reich, economista americano, professore di amministrazione e politiche pubbliche all’Università della California – Berkeley, ed ex Segretario del Lavoro sotto la presidenza Clinton, ha dichiarato che l’aumento della produttività e la perdita di posti di lavoro causati dell’intelligenza artificiale potrebbero richiedere una strategia di reddito di base universale.
A ottobre 2023, in occasione del Democracy Forum 2023 della Fondazione Obama, l’ex presidente Barack Obama ha discusso dell’impatto dell’automazione sul mercato del lavoro, della necessità di cambiamenti radicali e del potenziale di idee come la settimana lavorativa più corta e il reddito di base universale.
“Dovremo considerare una qualche forma di reddito universale di base”, ha dichiarato a novembre Vinod Khosla, già cofondatore di Sun Microsystems e notissimo investitore tramite Khosla Ventures in aziende tech e startup (inclusa OpenAI), sostenendo un impatto significativo dell’AI sulla crescita del PIL e sulla produttività, ma richiamando al contempo l’attenzione sulla crescente questione della disparità di reddito.
Nel frattempo l’ex governatore della Banca del Canada, Stephen Poloz, descriveva una forma di reddito di base come un importante “stabilizzatore automatico” per stabilizzare le economie che si trovino ad affrontare sostanziali stravolgimenti del mercato del lavoro dovuti a sviluppi tecnologici e AI.
Ancora a novembre 2023, durante l’ultimo AI Safety Summit, in un talk con il primo ministro inglese Rishi Sunak, Elon Musk ha affermato che gli sviluppi tecnologici dell’intelligenza artificiale ci condurranno verso un mondo in cui “non ci sarà bisogno di alcun lavoro” e che le persone potranno continuare a lavorare “per soddisfazione personale”. Al posto degli umani, in futuro l’intelligenza artificiale “sarà in grado di fare tutto”. Musk ha recentemente lanciato xAI, la sua startup dedicata allo sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale con cui ha creato Grok, il chatbot in grado di accedere al database pubblico di X (ex Twitter).
In un articolo sul proprio blog risalente al 2021, Sam Altman (CEO di Open AI) individuava nello sviluppo degli algoritmi di intelligenza artificiale l’emersione di una “Legge di Moore per ogni cosa”, facendo riferimento a un trend dell’industria informatica descritto da Gordon Moore e che prevedeva che il numero di transistor sui chip dei computer raddoppiasse circa ogni due anni.
“Dobbiamo progettare un sistema in grado di accogliere questo futuro tecnologico (quello dell’intelligenza artificiale, ndr),” spiega Altman, “ e tassare le risorse che avranno maggior valore in quel futuro – ovvero le aziende e la terra – così da distribuire equamente il benessere che emergerà,” continua. “Fare così renderà la società del futuro molto meno divisa e pensata per permettere a tutti di godere dei guadagni che genera”.
Nell’articolo, Altman descrive come – secondo lui, e senza fornire elementi concreti – gli algoritmi di intelligenza artificiale rimpiazzeranno progressivamente gli umani in ogni ruolo professionale, lasciandoci così a rispondere a due domande fondamentali: come si sopravvive senza un lavoro? Cosa faranno gli umani con tutto questo tempo libero? Altman evidenzia la necessità di tassare i patrimoni, più che i guadagni derivanti dal lavoro, permettendo così di ridistribuire a tutti queste risorse. “Il modo migliore per migliorare il capitalismo è permettere a chiunque di beneficiare direttamente dallo stesso come se fosse un’azionista”, ha affermato.
Una qualche forma di reddito di base universale è anche protagonista di studi e dibattiti sui forum dell’Altruismo Efficace, un movimento utilitarista particolarmente in voga tra i miliardari tech.
Ma molte di queste proposte restano affermazioni vaghe, quasi apolitiche, prive del come bisognerebbe arrivarci. E sembrano soprattutto un modo per enfatizzare la presunta importanza e impatto (e il valore, anche per gli investitori e le aziende) di queste tecnologie, più che una genuina messa in discussione di politiche redistributive.
Scott Santens, fondatore e presidente della Income to Support All Foundation, organizzazione americana che si batte per un reddito di base universale (che per altro ha come presidente Katie Moussouri, nota ricercatrice di cybersicurezza e Ceo di una società del settore), proprio in un dibattito su AI e lavoro ricorda come in passato gli aumenti di produttività abbiano avvantaggiato soprattutto i vertici.
“Per questo – afferma – ritengo importante considerare la questione del reddito di base universale come un dividendo della crescita della produttività. E mi auguro che, man mano che la crescita della produttività riceverà un’iniezione di energia dall’AI e dall’automazione in generale, si cominci a dire: “Bene, chi dovrebbe beneficiare? Per chi dovrebbero lavorare queste macchine?”. E il reddito universale di base significherebbe che l’automazione funziona per tutti”.
I progetti pilota e i network sul reddito di base
In Italia, questo interesse ha dato vita a organizzazioni come Basic Income Network. Nel resto del mondo, sono già molti i progetti pilota che stanno sperimentando l’implementazione del reddito universale di base. Il punto, però, più che avere a che fare con il futuro professionale degli umani, riguarda i processi attraverso cui viene prodotta la ricchezza e i modi in cui viene distribuita. Nel 2018, un articolo dell’Harvard Business Review teorizzava l’introduzione del concetto di “data dignity”, ovvero del diritto da parte degli utenti di veder riconosciuto un compenso per i propri dati utilizzati dai sistemi tecnologici di automazione.
Al netto dei punti di vista sulle possibilità di implementazione, un’economia che smette progressivamente di basarsi sul lavoro umano lascia un evidente interrogativo circa le superfici tassabili. Come si scioglie questo nodo?
La proposta di una Robot tax
Se diamo per assodato che la sostituzione di alcune o molte mansioni da parte di macchine sia una prospettiva inevitabile per tutti i livelli del mercato del lavoro, resta da chiedersi come si tassi un mercato del lavoro in cui una parte della forza lavoro è costituita da macchine, perlopiù immateriali come gli algoritmi.
In una ricerca pubblicata nel 2022 dalla macroeconomista Rossana Merola, si suggeriscono due possibili strade per la tassazione del lavoro svolto da macchine. La prima è la robot tax, ovvero una tassa sulle aziende che sostituiscono la forza lavoro umana con quella non-umana: se implementi un robot per rimpiazzare dei lavoratori umani, dovrai pagare una tassa per compensare le tasse che non stai pagando al lavoratore umano e quelle che il lavoratore umano pagherebbe sui propri guadagni. Questo gettito sarebbe poi implementato per finanziare forme di welfare pensate, nello specifico, per tutelare i lavoratori danneggiati dall’introduzione della forza lavoro non-umana.
La proposta di una Digital tax
In alternativa, Merola propone anche una digital tax – una tassa simile all’IVA pensata nello specifico per i prodotti digitali e che tenga in conto delle dinamiche che regolano le economie immateriali. Le superfici di intervento, approfondendo l’analisi, si moltiplicano: questa nuova apparente rivoluzione industriale ci obbliga a ricalcolare tutte le dimensioni di valore tassabili per un’azienda digitale che, spesso, diventa multinazionale e finisce per interagire con regimi fiscali diversi tra di loro (e con ampio margine di elusione).
Prove di reddito universale di base
Lo scenario è ancora nebuloso. Da un lato la ricerca dal punto di vista delle policy sostiene che politiche fiscali più aggressive non disincentivino le aziende a investire sull’AI. Dall’altro lato, l’impatto concreto nel mercato del lavoro è ancora tutto da dimostrare (soprattutto per le professioni con competenze trasversali) e l’elevatissima e rapida finanziarizzazione del settore fa temere la possibilità di una bolla pronta a scoppiare, come nel caso di quella relativa al mondo delle criptovalute e del web3. Ciò che conta, però, è la prospettiva del reddito universale di base. I programmi pilota, sebbene siano implementati in proporzioni ridotte, suggeriscono impatti positivi e virtuosi per le economie nazionali.
Per quanto riguarda gli algoritmi di intelligenza artificiale, sebbene il dibattito pubblico sul tema proponga posizioni forti (tra i tecno-utopisti e i tecno-catastrofisti), va comunque ricordato che una parte importante dell’infrastruttura tecnologica su cui si regge il funzionamento di questi sistemi si basa prevalentemente sul lavoro umano, che viene impiegato per classificare, correggere e rivedere i dataset utilizzati dagli algoritmi per il loro addestramento, o per dare feedback migliorativi ai sistemi.
E quindi, come mostrano gli studi e i libri di Kate Crawford, Mary L. Gray e Siddharth Suri, oltre alla eventuale scomparsa del lavoro, si dovrebbe parlare anche della possibilità che parte di quel lavoro sia invece meno visibile, rimanendo nascosto nelle pieghe della filiera produttiva dell’intelligenza artificiale e dei servizi correlati.
如有侵权请联系:admin#unsafe.sh
